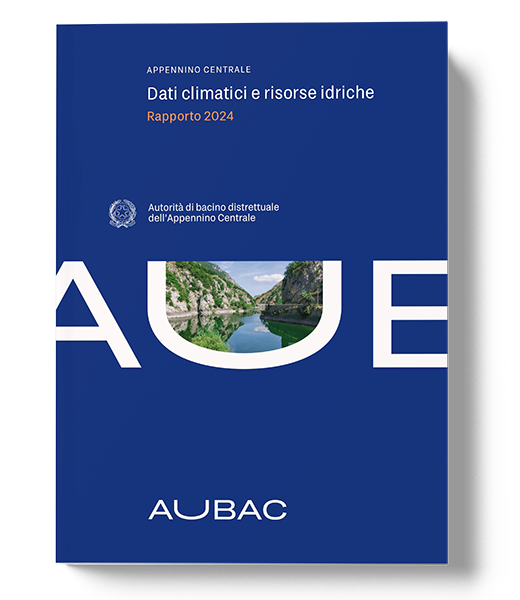Descrizione e commento generale
Il Rapporto AUBAC 2024, pubblicato nel 2025 dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale (AUBAC), fornisce una fotografia dettagliata dello stato climatico e delle risorse idriche del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale per l’anno 2024. Si tratta di un documento annuale tecnico-istituzionale che analizza i principali indicatori idrologici e climatici registrati nel corso del 2024, evidenziando fenomeni di stress idrico, vulnerabilità del territorio e alterazione degli equilibri naturali. In altre parole, il rapporto non è una semplice raccolta di dati, ma rappresenta uno strumento conoscitivo strategico: esso contribuisce a costruire una visione informata che possa guidare azioni concrete e investimenti coerenti con obiettivi di sostenibilità e adattamento ai cambiamenti climatici.
L’anno 2024, infatti, ha confermato in pieno la centralità della risorsa idrica per l’equilibrio ambientale, la tenuta dei sistemi produttivi e la sicurezza delle comunità. La crisi climatica in atto e le sue manifestazioni estreme, siccità prolungate, eventi meteorologici violenti, aumento della temperatura media, stanno ridisegnando il rapporto tra uomo, territorio e acqua, specialmente in un comprensorio eterogeneo come l’Appennino centrale (aree montane, pianure irrigue, bacini urbani ad alta densità…).
In questo contesto, disporre di dati aggiornati e di qualità diventa indispensabile: il rapporto sottolinea come la sola presenza di infrastrutture fisiche non sia più sufficiente a garantire una gestione idrica efficace; servono invece sistemi di monitoraggio capillari, modelli predittivi affidabili e indicatori climatici/idrologici continuamente aggiornati. I dati, se ben integrati e interpretati, divengono strumenti decisivi per anticipare criticità, calibrare le risposte operative e costruire politiche pubbliche mirate.
Il documento rappresenta dunque un tassello di questa “infrastruttura conoscitiva” a supporto del territorio. AUBAC, in qualità di ente tecnico-istituzionale, svolge un ruolo essenziale raccogliendo, elaborando e divulgando in modo sistematico i dati idro-meteo-climatici: ciò fornisce una solida base per comprendere le evoluzioni in corso e supportare le scelte di pianificazione. Il Rapporto AUBAC 2024 si colloca pienamente in questa missione, offrendo informazioni integrate che aiutano amministratori, gestori e cittadini a leggere con maggiore consapevolezza la realtà e ad affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico. In sintesi, il rapporto 2024 dell’AUBAC è un documento di riferimento che rappresenta sia uno stato dell’arte sulle condizioni idro-climatiche del Distretto, sia uno strumento di supporto decisionale per promuovere resilienza territoriale e gestione sostenibile delle risorse idriche.
Nota metodologica
Il Rapporto AUBAC 2024 è stato redatto dal gruppo tecnico-scientifico dell’Autorità, sotto il coordinamento del Segretario Generale, avvalendosi delle banche dati e dei sistemi di monitoraggio ambientale sviluppati da AUBAC stessa.
Nella Parte I del documento, dopo una breve presentazione dell’ente e dei suoi compiti istituzionali, viene descritto il territorio del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale e illustrato il sistema di monitoraggio ambientale utilizzato per la raccolta e l’analisi dei dati. AUBAC dispone infatti di un articolato sistema di rilevamento, che integra reti di sensori sul campo e dati telerilevati: stazioni meteorologiche (termometri, pluviometri, igrometri), idrometri fluviali, nivometri, oltre a dataset modellistici ad alta risoluzione spaziale (fino a 1 km) per uniformare la copertura dei dati su tutto il territorio. Tali fonti permettono di monitorare in continuo parametri climatici (temperature, precipitazioni, umidità, neve, radiazione solare) e idrologici (livelli e portate di fiumi, laghi e invasi) sull’intero Distretto.
I dati raccolti vengono poi validati, elaborati e confrontati con serie storiche di riferimento. In particolare, per valutare anomalie e trend, il rapporto adotta come periodo climatico di riferimento il trentennio 1991-2020, rispetto al quale sono calcolati gli scostamenti di temperatura e precipitazione. Inoltre, le condizioni di siccità vengono quantificate tramite indicatori standardizzati riconosciuti a livello internazionale, quali l’SPI (Standardized Precipitation Index) e lo SPEI (Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index), calcolati su diversi orizzonti temporali (3, 12 e 24 mesi). Questi indicatori consentono di distinguere la siccità meteorologica di breve periodo dalle tendenze siccitose di medio-lungo termine, offrendo un quadro oggettivo della severità idrica nel distretto.
Dal punto di vista strutturale, il rapporto è organizzato in quattro parti principali:
- Parte I – Il Distretto idrografico dell’Appennino Centrale: inquadra il contesto territoriale e istituzionale. Qui vengono presentati l’AUBAC (ruolo, funzioni e area di competenza) e i dati di base del Distretto (estensione, regioni coinvolte, popolazione, bacini idrografici, etc.), oltre a una descrizione del sistema di monitoraggio ambientale implementato. Questo fornisce al lettore le informazioni metodologiche su come e da dove provengono i dati utilizzati nel resto del rapporto.
- Parte II – Dati climatici: presenta le analisi sui dati meteorologici del 2024, in particolare temperatura dell’aria e precipitazioni. I risultati sono articolati per scala geografica (regione, Ambito Territoriale Ottimale o ATO, bacino idrografico e capoluogo di provincia) così da offrire un quadro completo e granulare del clima nel Distretto. Di ogni area territoriale vengono mostrati i valori mensili e annuali, con il confronto rispetto ai valori medi 1991-2020, in modo da evidenziare le anomalie termiche e pluviometriche del 2024. Tabelle e grafici aiutano a sintetizzare indicatori chiave come temperature estreme, numero di giorni di pioggia, eventi estremi, ecc.
- Parte III – Dati idrologici e severità idrica: raccoglie i dati relativi alle risorse idriche superficiali. In questa sezione il rapporto presenta innanzitutto l’andamento dei livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua, dei laghi naturali e degli invasi artificiali del Distretto nel 2024. Successivamente, viene descritta la situazione di siccità e deficit idrico manifestatasi nel corso dell’anno: attraverso gli indici SPI/SPEI e altri parametri, si delineano i quattro scenari di severità idrica previsti dalla normativa (da condizioni di normalità fino all’emergenza siccità) e si identifica quali di questi scenari hanno interessato il territorio in ciascun periodo. In aggiunta, questa parte include un’analisi sugli incendi boschivi verificatisi nel 2024, in quanto direttamente correlati alle condizioni meteoclimatiche estreme (siccità, ondate di calore) registrate.
- Parte IV – Mappe tematiche e indicatori: costituisce un approfondimento cartografico e statistico su scala locale. Vengono fornite mappe e schede sintetiche per ciascuno dei 18 ATO e dei 15 capoluoghi di provincia del Distretto. Per ognuno di questi sub-ambienti territoriali, il rapporto offre una rappresentazione completa dei valori mensili registrati nel 2024 (piogge, neve, temperature medie, umidità relativa, radiazione solare) e dei principali indicatori climatici derivati, come ad esempio il numero di notti tropicali (giorni con temperatura minima > 20°C), il numero di giorni di gelo (minime ≤ 0°C), il numero di giorni di pioggia consecutivi e altri. Questa sezione finale, fortemente visuale, permette di cogliere immediatamente le differenze territoriali all’interno del Distretto e di identificare le aree più colpite da fenomeni siccitosi o eventi estremi.
Dal punto di vista delle fonti dati, il rapporto fa affidamento esclusivo su dati interni o istituzionali relativi al Distretto Appennino Centrale. Non vengono utilizzate fonti esterne non validate: il focus è sui dataset prodotti o acquisiti da AUBAC nell’esercizio delle sue funzioni (monitoraggi propri, dati raccolti da altri enti nel territorio, elaborazioni modellistiche dedicate).
In termini di processo metodologico, i dati grezzi vengono analizzati da AUBAC mediante strumenti statistici e GIS, e presentati con un linguaggio divulgativo ma rigoroso, per favorire la comprensione anche da parte di un pubblico non specialistico. Ogni sezione include infografiche, tabelle e commenti testuali che spiegano i risultati più salienti. Infine, il rapporto comprende un glossario dei termini tecnici per facilitare la lettura e contestualizzare indicatori e definizioni specialistiche.
Principali risultati del 2024 e loro rilevanza
TEMPERATURE ECCEZIONALMENTE ELEVATE
Tutte le regioni del distretto hanno registrato nel 2024 temperature medie annue superiori alla media climatica 1991-2020 di circa +1,9 °C. Questo marcato riscaldamento (fino a +2 °C in Umbria) conferma gli effetti del cambiamento climatico, comportando maggiore evaporazione, stress per gli ecosistemi e aumento della domanda idrica (agricola e civile).
PRECIPITAZIONI RIDOTTE E CONCENTRATE
Il totale annuo di pioggia è risultato inferiore del 14% rispetto alla norma 1991-2020 su tutto il territorio, con deficit particolarmente severi in Abruzzo (-25%), Lazio (-24%) e Umbria (-16%). Gli indici siccità (SPI/SPEI a 12-24 mesi) sono risultati negativi in tutte le regioni, segnalando una condizione di siccità diffusa (specialmente in Lazio e Abruzzo). I mesi più aridi sono stati novembre, luglio, aprile, giugno, gennaio e febbraio, mentre solo settembre e ottobre hanno avuto piogge sopra la media (ottobre ha registrato accumuli anche doppi del normale in Marche, Umbria e Lazio). Tuttavia, queste precipitazioni autunnali intense non hanno ricaricato adeguatamente le falde acquifere a causa dell’elevata intensità e rapidità del ruscellamento. Il deficit pluviometrico prolungato è cruciale poiché riduce la disponibilità di acqua per usi potabili e agricoli e può aggravare la siccità nei mesi successivi.
NEVICATE STRAORDINARIAMENTE SCARSE
Il 2024 ha visto un crollo delle precipitazioni nevose, risultate in media l’83% inferiori al periodo 2010-2020. In regioni come Toscana e Umbria la neve è praticamente mancata (–92% e –88% rispetto al normale). Di conseguenza, l’equivalente idrico nivale (Snow Water Equivalent) è stato inferiore del 71% rispetto alla media di riferimento. Ciò è estremamente rilevante in quanto lo scarso accumulo di neve invernale implica minore acqua di fusione disponibile in primavera/estate, riducendo l’alimentazione di fiumi, falde e bacini irrigui proprio nel periodo di maggior bisogno.
PORTATE FLUVIALI ED ECOSISTEMI IN STRESS
A causa della combinazione di scarse piogge e temperature elevate, nel 2024 i deflussi della maggior parte dei corsi d’acqua sono scesi ben al di sotto delle medie stagionali e, in alcuni casi, perfino sotto i valori minimi vitali di deflusso ecologico. In estate molti fiumi hanno registrato portate ai minimi storici. Ciò comporta conseguenze importanti: gli habitat acquatici e la fauna fluviale subiscono condizioni critiche (bassi livelli d’ossigeno, concentrazione di inquinanti), mentre gli usi antropici (idrico-potabile, irriguo, energetico) vanno in sofferenza, aumentando il rischio di razionamenti e conflitti tra utenti dell’acqua.
DIMINUZIONE DEI VOLUMI NEGLI INVASI
I grandi bacini artificiali del distretto hanno risentito della siccità. Escludendo il solo invaso di Montedoglio (Toscana), tutti gli altri invasi hanno presentato livelli di riempimento estivi inferiori a quelli dell’anno precedente; a fine settembre 2024 si osservavano volumi ridotti del 20–40% rispetto al 2023. Ad esempio, invasi strategici per uso idropotabile/irriguo come Penne (Abruzzo) e Mercatale (Marche) hanno toccato percentuali medie annue di riempimento molto basse (14% e ~47% rispettivamente). La riduzione delle scorte idriche immagazzinate è un dato allarmante poiché limita la capacità di fronteggiare i fabbisogni durante eventuali futuri periodi secchi e può ridurre la produzione idroelettrica, evidenziando la necessità di gestione oculata della risorsa.
INCREMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI
La prolungata siccità e le ondate di calore hanno contribuito a un forte aumento degli incendi. Nel 2024 si sono verificati 461 incendi boschivi nel distretto (pari al 18% del totale nazionale), che hanno bruciato 6.336 ettari di superficie (19% del totale nazionale). Rispetto al 2023 c’è stato un netto peggioramento (+87 roghi e +2.365 ha bruciati). Il Lazio è risultata la regione più colpita (69% degli incendi e 82% della superficie bruciata, con la sola provincia di Latina che ha registrato 166 incendi). Oltre il 77% degli incendi si è concentrato nei mesi di luglio e agosto, periodo di massimo stress idrico per la vegetazione. Questo trend è importante perché indica un aumento della vulnerabilità del territorio a fenomeni di incendio in condizioni climatiche estreme, con gravi ripercussioni ecologiche (perdita di boschi, biodiversità) e socioeconomiche (danni a proprietà, costi di spegnimento e emissioni in atmosfera).
Sommario
Prefazione di Mario Rosario Mazzola
Prefazione di Massimo Gargano
Introduzione di Marco Casini
PARTE PRIMA: IL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO CENTRALE
AUBAC
Il distretto dell’appennino centrale
L’osservatorio sugli usi idrici
Il sistema di monitoraggio ambientale
PARTE SECONDA: DATI CLIMATICI
Temperatura dell’aria
Precipitazioni
PARTE TERZA: DATI IDROLOGICI E SEVERITÀ IDRICA
Corsi d’acqua
Laghi naturali
Invasi artificiali
Severità idrica
Incendi boschivi
PARTE QUARTA: MAPPE TEMATICHE E INDICATORI
Ambiti territoriali ottimali
Capoluoghi di provincia
GLOSSARIO
AUBAC, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale
L'AUTORITÀ
L’AUBAC, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, è un ente pubblico incaricato di pianificare e coordinare la gestione del territorio e delle risorse idriche nell’Italia centrale. In particolare, è responsabile della programmazione e pianificazione per la mitigazione del rischio idrogeologico, la tutela e l’uso sostenibile delle risorse idriche, nonché la difesa delle coste e del suolo nel proprio distretto. La sede principale dell’ente è a Roma e l’organico conta 127 dipendenti (oltre al Segretario Generale), distribuiti in 10 uffici dirigenziali.
DATI DI CONTESTO
Il distretto idrografico dell’Appennino Centrale copre un territorio vasto (oltre 42.000 km²) che abbraccia 7 regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria). Al suo interno ricadono 22 province e 901 comuni (tra cui 15 capoluoghi di provincia e 4 di regione), dove risiedono circa 9 milioni di abitanti. Si tratta di un’area eterogenea che comprende circa 800 km di coste (affacciate sui mari Tirreno e Adriatico) e una fitta rete idrografica composta da 49 bacini principali, con 371 corsi d’acqua rilevanti e 39 laghi, oltre a falde sotterranee e corpi idrici costieri.
Nel distretto insistono importanti infrastrutture idriche, tra cui 49 grandi dighe (che invasano complessivamente oltre 1.500 milioni di m³ d’acqua) e 384 impianti idroelettrici con circa 2.000 MW di potenza installata, capaci di produrre ~4.800 GWh all’anno. Queste cifre evidenziano la complessità ambientale e socioeconomica della regione in cui AUBAC opera: dalle zone montane appenniniche alle pianure agricole e aree metropolitane (Roma inclusa), fino ai litorali costieri.
Le decisioni e i piani dell’Autorità di bacino hanno dunque un impatto diretto su una popolazione numerosa e su attività strategiche (come l’agricoltura mediterranea di qualità e la produzione energetica), rendendo fondamentale il suo operato per promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile dell’Appennino centrale.
PRINCIPALI FUNZIONI E RESPONSABILITÀ
Pianificazione distrettuale: elaborazione e continuo aggiornamento del Piano di bacino distrettuale e dei relativi piani di settore (PGA, PGRA, PAI, PGC e PGS). Questi strumenti pianificatori definiscono le strategie a medio-lungo termine per la sicurezza idraulica, la tutela qualitativa e quantitativa dell’acqua e l’uso sostenibile del territorio.
Studi tecnici e regolamentazione: predisposizione di bilanci idrici (analisi del bilancio tra disponibilità e fabbisogni d’acqua), elaborazione di mappe di pericolosità e di rischio (ad esempio aree esondabili o soggette a dissesto idrogeologico) e sviluppo di strumenti normativi e linee guida per governare le trasformazioni territoriali in modo sostenibile. Ciò fornisce basi conoscitive e regolatorie essenziali per gli enti locali e altri stakeholder, assicurando che le decisioni di uso del suolo e delle risorse idriche tengano conto dei rischi ambientali.
Pareri e concessioni idriche: espressione di pareri tecnico-ambientali obbligatori su progetti e interventi nel distretto (per verificare la compatibilità con la pianificazione di bacino) e rilascio delle concessioni per le grandi derivazioni idriche (prelievi di acqua da fiumi o laghi di notevole entità). AUBAC fornisce inoltre indirizzi e criteri per regolamentare i prelievi e gli usi idrici sul territorio, al fine di equilibrare i diversi bisogni (civili, agricoli, industriali) con la salvaguardia dell’ambiente.
Coordinamento dei Consorzi di bonifica: supervisione e indirizzo verso i Consorzi di bonifica locali, enti preposti alla gestione di reti di canali, irrigazione e drenaggio. Il coordinamento garantisce che l’azione quotidiana dei Consorzi (es. manutenzione di canali, opere idrauliche minori) sia coerente con gli obiettivi generali di bacino e contribuisca alla riduzione del rischio idrogeologico.
Misure di tutela e mitigazione: pianificazione e programmazione di interventi concreti finalizzati sia alla riduzione del rischio (ad esempio opere per la difesa dalle alluvioni, consolidamento di versanti franosi) sia alla tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi fluviali. Tali misure implementano sul territorio le indicazioni dei piani, migliorando la resilienza ambientale e la sicurezza delle comunità.
Osservatorio sugli usi idrici: gestione dell’Osservatorio permanente del distretto, organo tecnico attraverso cui AUBAC monitora costantemente le condizioni meteo-climatiche e idrologiche (livelli dei fiumi, stato dei laghi e falde, piogge, nevicate, ecc.), valuta gli scenari di severità idrica (siccità in atto o potenziale) e individua le misure più adeguate a mitigare gli impatti della scarsità d’acqua. L’Osservatorio emette periodicamente un Bollettino informativo sullo stato idrico del distretto, segnalando eventuali situazioni critiche, i rischi per la popolazione e le misure adottate o raccomandate.
Collaborazione interistituzionale: tutte le attività di AUBAC si svolgono in stretta sinergia con una vasta rete di soggetti pubblici e anche privati. L’ente fornisce inoltre supporto tecnico alle autorità commissariali e regionali in situazioni di emergenza o post-evento (es. la messa in sicurezza di aree colpite da alluvioni o terremoti), e interagisce con gli organi dello Stato (Parlamento, Governo) tramite relazioni e audizioni sulle tematiche di competenza, contribuendo al processo decisionale nazionale in materia ambientale.
Progetti speciali e innovazione: l’Autorità è attivamente coinvolta in progetti speciali, accordi e programmi sia nazionali che europei finalizzati a sperimentare soluzioni innovative per la tutela e la valorizzazione del territorio. Ad esempio, AUBAC può essere ente attuatore o beneficiario di progetti di ricerca scientifica, studi di fattibilità per nuove opere idrauliche, iniziative pilota per l’adattamento al cambiamento climatico o interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture idrauliche. Queste progettualità aggiuntive testimoniano l’impegno dell’ente nel migliorare continuamente le conoscenze e gli strumenti a disposizione per la gestione sostenibile del distretto.
L’IMPATTO SOCIALE ED AMBIENTALE
Dal punto di vista dell’impatto sociale e ambientale, il ruolo di AUBAC è cruciale. Attraverso la sua azione, l’ente protegge gli ecosistemi acquatici (fiumi, laghi, zone costiere), preservando la biodiversità e la qualità ecologica dei corsi d’acqua, e allo stesso tempo tutela le comunità umane mitigando i rischi di alluvioni, frane e siccità.
Una gestione pianificata e basata su dati aggiornati garantisce una disponibilità idrica sostenibile per usi civili (acqua potabile), agricoli (irrigazione per colture importanti del Centro Italia) ed energetici (idroelettrico), contribuendo alla sicurezza alimentare, salute pubblica e stabilità economica dell’area.
L’attività di raccolta ed elaborazione dati di AUBAC fornisce strumenti di conoscenza a decisori e cittadini, aumentando la consapevolezza ambientale e favorendo politiche di adattamento ai cambiamenti climatici basate su evidenze solide. In questo senso, AUBAC funge da garante tecnico per uno sviluppo territoriale resiliente e attento sia alla salvaguardia dell’ambiente sia al benessere della popolazione del distretto.